Tra Vetus e Novus Ordo. È possibile la pace liturgica? È un approfondimento del prof. Lanni Cristian su questo tema tanto attuale ma sul quale c’è molta confusione. Altri approfondimenti sulla liturgia sono nella nostra rubrica: ABC Liturgico.
Radici della vicenda e vexatae quaestione

In due articoli, che certamente non hanno la pretesa di esaurire la vasta tematica in questione, cercheremo di inquadrare e riflettere sulla tematica della Liturgia e i cambiamenti ad essa apportati nel corso del XX secolo dai Romani Pontefici. Dapprima uno sguardo storico e di sottolineatura delle questioni più dibattute e, successivamente, una riflessione sui due Motu Proprio che maggiormente sono oggetto di diatriba: il Summorum Pontificum ed il Traditiones Custodes, per addivenire poi ad un tentativo di sintesi.
In questo primo contributo, appunto un excursus storico e la presentazione delle tematiche più sentite.
Un breve excursus della vicenda
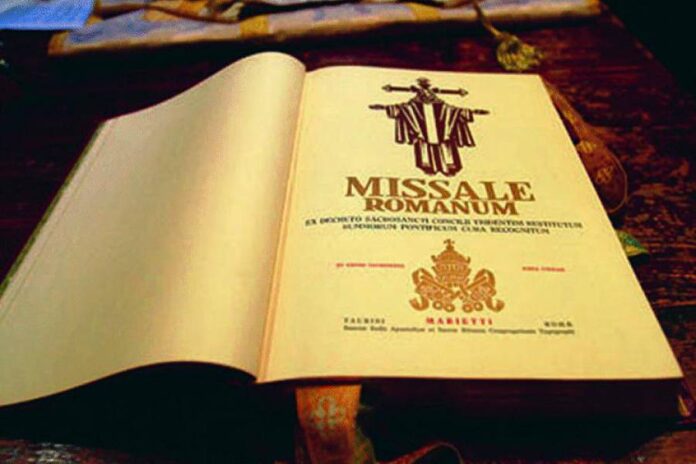
A seguito della promulgazione della Costituzione Apostolica Missale Romanum da parte di Paolo VI il 3 aprile del 1969, il precedente Rito promulgato nel 1570 da Pio V, a seguito del Concilio di Trento veniva riformato secondo i dettami stabiliti dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Quest’ultimo, infatti nella Sacrosanctum Concilium, afferma che «l’ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà, da essi significate, siano espresse più chiaramente» [1]. Tuttavia, al contrario di quanto generalmente si possa pensare, la riforma di Paolo VI non succede immediatamente quella di Pio V. Infatti, nel 1903, il Pontefice Pio X, tentando di ovviare alla partecipazione assolutamente passiva dei fedeli alla Celebrazione Eucaristica promulgò il motu proprio Inter sollicitudines, in parziale riforma, affermando che «la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa” è la “prima e indispensabile fonte” del “vero spirito cristiano». Lo stesso Pontefice, nel 1911 abolì completamente la disposizione dei salmi stabilita nel Breviario romano di Pio V, distribuendoli in modo da avere all’incirca lo stesso numero di versetti nell’ufficio di ogni giorno. Riformò anche le rubriche riguardanti la priorità tra il santorale e gli altri uffici: la moltiplicazione delle feste dei Santi, infatti, aveva reso molto rara la celebrazione delle domeniche e delle ferie, e di conseguenza la recita di alcuni salmi. Questi cambiamenti resero necessaria la modifica anche del Messale romano, che avvenne nella Editio typica del 1920 promulgata da Benedetto XV. Nel 1947, Pio XII istituì una commissione per la revisione dei libri liturgici, dopo aver condannato nello stesso anno, con l’Enciclica Mediator Dei ogni abuso e travisamento del rito, ribadendo l’azione lodevole di quanti cercavano di avvicinare sempre più i fedeli alla Celebrazione Eucaristica. La commissione fu assorbita, nel 1959 nella commissione preparatoria ai lavori del Concilio. Lo stesso Pio XII negli anni dal 1951 al 1955 mutò profondamente alcune parti della liturgia romana, in particolare la celebrazione del Triduo pasquale e della Domenica delle Palme. Abolì il can. 821 del Codex Juris Canonici [2] del 1917 e così ordinò che si celebrassero le liturgie del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della Veglia pasquale, con testi nuovi, nel pomeriggio o nella sera, mentre Pio V aveva qualificato come un abuso, un allontanamento dall’antico uso della Chiesa cattolica e dai decreti dei Santi Padri, la celebrazione della messa dopo l’ora indicata nei canoni, particolarmente se si iniziasse la messa appena poco prima del tramonto. L’ultima grande riforma liturgica antecedente a quella Conciliare, fu operata da Giovanni XXIII che apportò sostanziali modifiche al calendario liturgico e alle rubriche della Liturgia delle Ore e della Messa di rito romano, modifiche poi incorporate nell’edizione del Messale romano pubblicata nel 1962 e nella quale, tra l’altro, modificò il canone della Messa, introducendo il nome di San Giuseppe. Dichiarò che «i principi più basilari sulla revisione generale della liturgia» [3] sarebbero proposti ai Padri del prossimo concilio ecumenico. Il risultato fu la costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Si pensi che nel 1962, nella messa di apertura del Concilio Vaticano II, la comunione non fu distribuita. Vi partecipavano centinaia di vescovi, ma solo chi presiedeva ricevette la comunione gli altri sono stati comunicati dopo la Messa. Soltanto il 3 ottobre del 1984, il Pontefice Giovanni Polo II, tramite una lettera circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti [4] dopo un quadriennio in cui le stesse Conferenze Episcopali furono invitate a riflettere sulla ricezione del nuovo Messale, sulle difficoltà di attuazione della riforma liturgica e circa eventuali resistenze, concesse previo indulto del Vescovo diocesano di poter celebrare la Santa Messa secondo il Messale del 1962, attenendosi a precise disposizioni, ovvero: «a) Con ogni chiarezza deve constare anche pubblicamente che questi sacerdoti ed i rispettivi fedeli in nessun modo condividano le posizioni di coloro che mettono in dubbio la legittimità e l’esattezza dottrinale del Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970. b) Tale celebrazione sia fatta soltanto per l’utilità di quei gruppi che la chiedono; nelle chiese ed oratori indicati dal Vescovo (non, però, nelle chiese parrocchiali, almeno che il Vescovo lo abbia concesso in casi straordinari); e nei giorni e alle condizioni fissate dal Vescovo sia abitualmente che per singoli casi. c) Queste celebrazioni devono essere fatte secondo il Messale del 1962 ed in lingua latina. d) Deve essere evitata ogni mescolanza tra i testi ed i riti dei due Messali. e) Ciascun Vescovo informi questa Congregazione delle concessioni da lui date e, trascorso un anno dalla concessione dell’indulto, riferisca sull’esito della sua applicazione» [5].
Alcune vexatae quaestiones sulla Liturgia

Il punto non è banale: se il fine dell’uomo è conoscere, amare e servire Dio, allora diviene del tutto essenziale il modo in cui ci si pone di fronte a Lui per riceverne i doni sacramentali, per espiare le proprie cadute, per rendere grazie della salvezza offerta in Cristo. La vita cristiana è un rapporto personale con il Padre che chiama a sé i suoi figli; è dunque fondamentalmente dialogo. Questo dialogo può ben essere privato e individuale; ma per essere realmente tale ha comunque bisogno di essere sorretto e quasi immerso in quel perenne canto d’amore della Sposa per il suo Sposo che è la liturgia pubblica della Chiesa. E questo canto ha ritmi e tonalità tutti propri, che divengono essi stessi contenuto, e non meramente forma. Lex orandi, lex credendi, dicevano i cristiani dei primi secoli: i modi e le forme del pregare pubblico, liturgico determinano i contenuti del credere. E, storicamente, è innegabile che i cambiamenti avvenuti nella lex orandi accompagnano e segnalano invariabilmente parallele mutazioni delle accentuazioni e della comprensione dei contenuti di fede.
La prima questione: la liturgia non è prodotto umano. In generale, si può ritenere valida l’affermazione per cui la riforma liturgica conciliare non sia stata applicata bene, secondo gli intenti del Concilio. Oggi la liturgia è una res della comunità. Quest’ultima, però, rappresenta se stessa, e troppo spesso si disegna una “liturgia creativa” che bada più alla presenza delle esperienze personali che all’incontro con la Presenza del Signore nella Chiesa; e con questa creatività e questa auto-presentazione della comunità rischia di scomparire l’essenza della liturgia, con la quale possiamo superare le nostre proprie esperienze e ricevere ciò che non deriva da esse, ma che è un dono di Dio. Tuttavia ciò che va restaurato non è tanto l’esteriorità di alcune cerimonie o paramenti, ma l’idea essenziale della liturgia: capire che nella liturgia non rappresentiamo noi stessi, ma riceviamo la grazia della presenza del Signore nella Chiesa del cielo e della terra. La liturgia è ultramondana e questo introduce alla seconda questione. Questo carattere ultramondano della liturgia ne determina altri due apparentemente in contrasto fra loro. Da una parte, essa è “predeterminata” e “imperturbabile”, sottratta quindi agli arbitri del celebrante della comunità o del celebrante. D’altra parte essa non è fissa in senso assoluto. Come tutte le forme della Chiesa, la liturgia accompagna l’uomo nel suo corso storico; e come mutano le condizioni storiche e culturali dell’uomo, anche essa può mutare, e di fatto è mutata. Ma lo fa in modo «organico» [6]. Ciò significa che la liturgia cresce e si modifica come lo fanno gli organismi vitali, cioè lentamente, senza strappi, e in virtù non di forze esterne ma di un impulso vitale interno. Così come avviene nelle Chiese orientali, e come è sempre avvenuto anche in Occidente fino a tempi recenti, i cambiamenti possono sopraggiungere, ma devono essere interpretabili nel senso della continuità con l’esistente; e il giudizio su di essi non deve soggiacere solo alla Gerarchia: è anche l’uso e l’accettazione dei fedeli che, nei secoli, determina l’accoglimento di una modifica o la soppressione di un’altra. Ecco perché nessuna riforma può presentarsi come un “nuovo edificio” costruito a supplenza di un vecchio demolito, ma piuttosto come una miglioria, un elemento sì nuovo, ma radicato e ben saldo nel vecchio, frutto di uno sviluppo organico ed armonioso.
Come più volte ricordato dai Pontefici nella storia, altro punto imprescindibile è l’actuosa partecipatio. Come si sa, questo è stato di solito interpretato nel senso di una condanna al preteso ruolo “passivo” a cui la liturgia tradizionale avrebbe relegato i fedeli. Purtroppo questa espressione è stata molto presto fraintesa e ridotta al suo significato esteriore, quello della necessità di un agire comune, quasi si trattasse di far entrare concretamente in azione il numero maggiore di persone possibile il più spesso possibile. La parola «partecipazione» rinvia, però, a un’azione principale, a cui tutti devono avere parte. Quale sarà dunque in realtà questa actio a cui tutta l’assemblea è chiamata, ora come sempre, a partecipare? Di solito si è dato a questa domanda la risposta pratica di moltiplicare e distribuire a quante più persone possibile i servizi paraliturgici durante la celebrazione “Con il termine «actio», riferito alla liturgia, si intende (nelle fonti) il canone eucaristico. La vera azione liturgica, il vero atto liturgico, è la oratio: la grande preghiera, che costituisce il nucleo della celebrazione liturgica e che proprio per questo, nel suo insieme, è stata chiamata dai Padri con il termine oratio. Ma come possiamo noi avere parte a questa azione? Dobbiamo pregare perché il sacrificio del Lògos diventi il nostro sacrificio, perché noi stessi, come abbiamo detto, veniamo trasformati e diveniamo così vero corpo di Cristo: è di questo che si tratta. Se le singole azioni esteriori, che di per sé non sono molte e che vengono artificiosamente accresciute di numero, diventano l’essenziale della liturgia e questa stessa viene degradata in un generico agire, allora viene misconosciuto il vero teodramma della liturgia, che viene anzi ridotto a parodia. Ogni celebrazione che riduce il divino sacrificio ad una serie meccanica di gesti è solo parodia del vero ed unico Sacrificio Eucaristico.
L’ultima vexata quaestio che vogliamo sottolineare è, indubbiamente, quella relativa all’uso della lingua latina, sempre rimasta “ufficiale” per la liturgia [7]. Ed è forse questo il segno più lampante della cattiva applicazione della riforma liturgica che intervenne permettendo in talune circostanze (letture e monizioni, per esempio) l’uso del volgare. A tal proposito si rendono opportune due osservazioni: è stato positivo tradurre la liturgia in lingue autoctone, perché così facendo la si è resa più prossima, più vicina al fedele permettendogli di prenderne parte in maniera profondissima, anche con il pensiero. Tuttavia, una marcata sottolineatura di alcune parti in latino, di alcuni elementi, aiuterebbe a rendere meglio la dimensione universalistica, a far sì che in tutte le parti del mondo si possa dire: «io sono nella stessa Chiesa». Perciò in generale, le lingue parlate sono una soluzione, ma una qualche presenza del latino potrebbe essere utile per avere una maggiore esperienza di universalità. Oltre al latino, tuttavia è caduta, ci permettiamo di osservare, anche un’altra lingua liturgica: quella del silenzio. Sotto l’influsso dell’interpretazione sociologica dell’actuosa partecipatio, si è perso l’uso della partecipazione anche silenziosa della liturgia. Espressione massima del Mistero dinanzi cui si è presenti, è spesso ridotta a pochi attimi al momento dell’elevazione.
Prof. Cristian Lanni
[1] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia: Sacrosanctum Concilium, n. 21;in AAS, LVI (1964), 106.
[2] Il quale proibiva di iniziare una Celebrazione Eucaristica in un orario che superasse di un’ora mezzogiorno.
[3] Lo afferma nel motu proprio Rubricarum instructum del 25 luglio 1962
[4] cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali: Quattuor abhinc annos, in www.unavox.it.
[5] Ibidem.
[6] Sacrosanctum Concilium, n.23.
[7] Sacrosanctum Concilium, n.36.